![LEONE DA TASTIERA? MEGLIO ACARO, COSÌ FORSE S’ AMMOSCIA E LA SMETTE [1 giornale italiano (“BERGAMONEWS”)] LEONE DA TASTIERA? MEGLIO ACARO, COSÌ FORSE S’ AMMOSCIA E LA SMETTE [1 giornale italiano (“BERGAMONEWS”)]](https://www.romacampodeifiori.academy/wp-content/uploads/2025/01/Pinterest_-_Italia_8.jpg)
![LEONE DA TASTIERA? MEGLIO ACARO, COSÌ FORSE S’ AMMOSCIA E LA SMETTE [1 giornale italiano (“BERGAMONEWS”)] LEONE DA TASTIERA? MEGLIO ACARO, COSÌ FORSE S’ AMMOSCIA E LA SMETTE [1 giornale italiano (“BERGAMONEWS”)]](https://www.romacampodeifiori.academy/wp-content/uploads/2025/01/Pinterest_-_Italia_8.jpg)
*

*

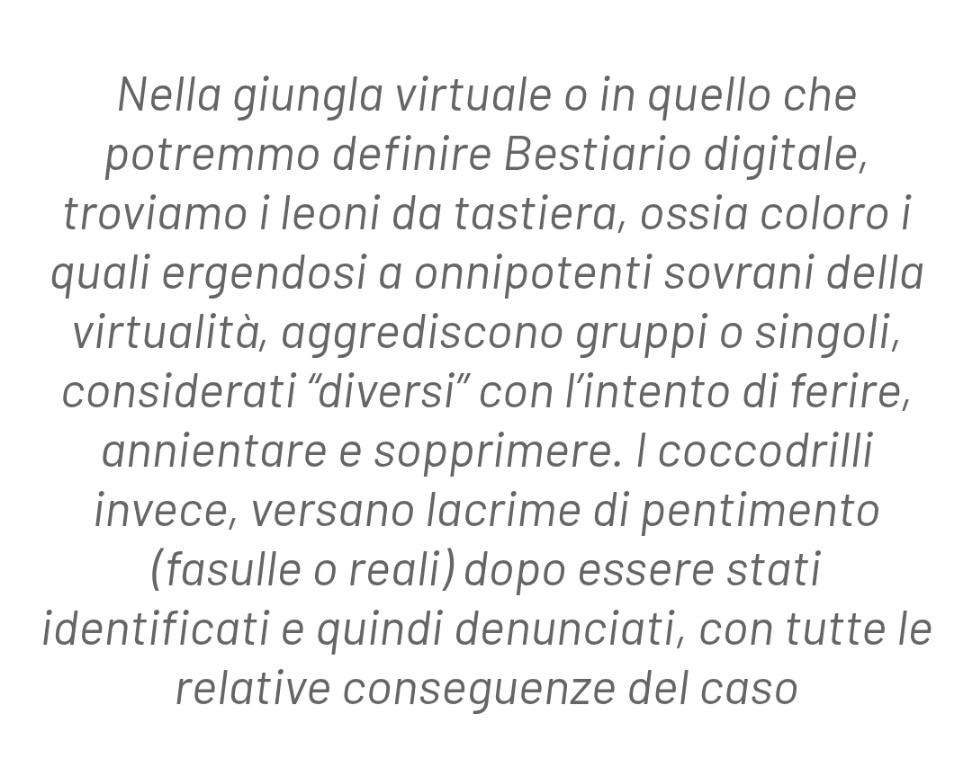
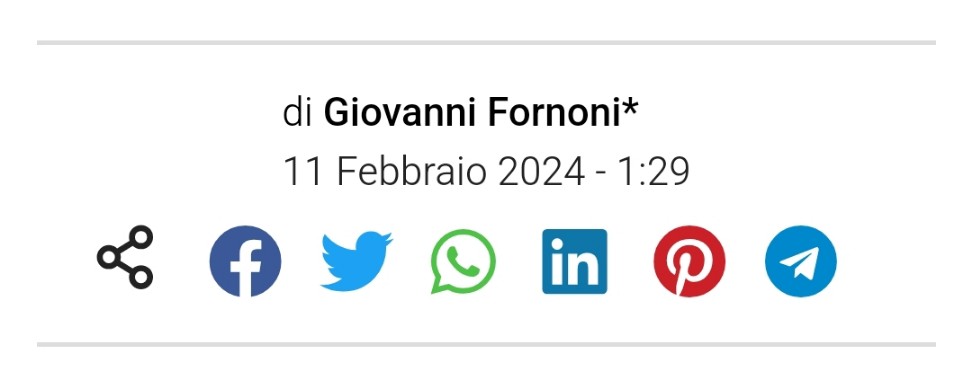
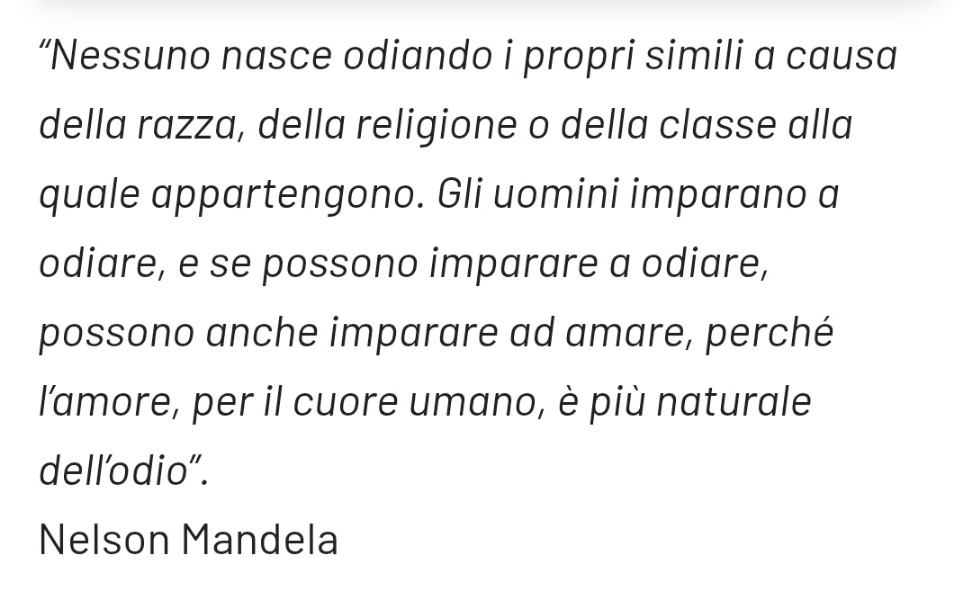
*
DI WALTER GALASSO
L’odio non è congenito, innato, radicato nel DNA, parte integrante della quintessenza di una persona. Sorge molto tempo dopo il primo vagito, nel diacronico flusso dell’esperienza, come bacato frutto empirico di interazioni con l’altro e l’altrove. Giovanni Fornoni, cresciuto culturalmente a Milano, nell’Accademia di Belle Arti di Brera, in un suo Bestiario su “BergamoNews”, dedicato proprio all’Hate-Speech, “Odio dunque sono”, prende le mosse, nel viaggio intellettuale del suo scritto, dal suddetto concetto, per l’esattezza dalla sua formulazione ad opera di Nelson Mandela, che ha voluto, con la negazione di una natura universale e ineluttabile del livore, imboccare un sentiero di pedagogico ottimismo.
Bando all’idea che non ci sia nulla da fare contro la perversa finalizzazione dell’energia interiore al male altrui. Ogni nascita umana è eticamente neutra, al di là del bene e del male. Un bebè è la possibilità di qualsiasi futuro, e pure l’uomo adulto più canaglia e satanasso è tale nella misura in cui il suo Io non ha avuto la fortuna di evolversi nella fratellanza, regredendo nell’esponenziale esaltazione dell’astio. Per Mandela la cattiveria si impara, in un apprendimento che, quantunque depravato, sintomatico di un’implosione della logica nei moti del cuore, può al tempo stesso, se letto da un altro angolo visuale, essere interpretato come un paradossale segno di speranza, sia pur più teorica che concreta. Se un incallito criminale, o comunque un uomo ben lontano da uno stinco di santo, è un ceffo che ha imparato la sua malvagità, allora vuol dire che avrebbe potuto anche non impararla, e che avrebbe potuto imparare il contrario del suo vizio: il rispetto del prossimo, una razionale comprensione del suo valore, una psicologica apertura alla consapevolezza di quanto gli altri meritino benevolenza in quanto simili. Per Nelson Mandela, anzi, in qualsiasi persona allo stato puro e originario l’amore non solo non è impossibile a priori, ma rappresenta la direzione più probabile e facile fra tutte quelle che la vita di un bambino può imboccare man mano che diventi un soggetto più esperto.
L’autore di questo articolo prende le mosse da questa alta citazione, inclusiva della rosea probabilità di un futuro migliore, per poi tuffarsi drammaticamente nella dura realtà, che, al netto della verità del magistero di Mandela, è ammorbata da tanti, troppi casi in cui ha fatto una brutta fine la sua idea “l’amore, per il cuore umano, è più naturale dell’odio”. Questo brusco cambio di registro non vuole mancare di rispetto all’illustre maestro, né confutare con un’obiezione tranchant la liceità del suo messaggio di pace. Semmai questa maniera di impostare lo scritto è orientata a lumeggiare i dilaganti percorsi della cattiveria contestualmente alla sottolineatura che essa, sempre e comunque, s’innesta, nell’eziologia della sua proliferazione, su un evitabile errore. Forte da un lato, la sua energia è un gigante dai piedi d’argilla se vista da un’altra angolazione. Essa è perché qualcosa l’ha agevolata, catalizzata, iniettando nella capillare rete dei suoi scuri atomi un esterno motivo che ne ha reso possibile la corrotta elefantiasi. Non è per forza, non regna in quanto legge universale, ma deve dire grazie a una causa scatenante, a un pessimo motore che le ha tenuto bordone in una propulsione simile all’espansione di un virus.
Il giornalista, nell’allusione ai pessimi tempi in cui l’umanità versa, nella dilagante penuria d’uno spirito di ecumenica fratellanza, punta subito il dito su un preciso imputato: lo spirito aggressivo che serpeggia nei lati meno luminosi dentro l’avvento, relativamente recente, dei social media. Galassie che sono permeate di splendidi valori, ma hanno pure, nel retro di questa positività, il neo di poter ospitare, nella loro oceanica latitudine, la deriva patologica di animi aggressivi.
Giova a questo proposito una precisazione: i social network inglobano questo pericolo esattamente come nell’oceano è più probabile, rispetto a un laghetto, l’incontro con un famigerato squalo, senza che questo alto tasso di rischio significhi che l’Oceano Pacifico non ha un miliardo di motivi per essere lodato e ammirato. Medietas, dunque, nell’elaborazione di giudizi sui social media. Non bisogna buttare il bambino con l’acqua sporca.
Giovanni Fornoni, sulla base di questa premura metodologica, mette subito alla berlina il fulcro dell’inquinata acqua social, citando “Countering Online Hate Speech”, l’opera in cui l’Unesco enuclea con esaustiva precisione le differenze basilari fra odio extraRete e il suo fratello online. L’astio in Internet, il fascio di linguaggi che lo veicolano, ha una durata tendenzialmente maggiore, grazie a una eco che si propaga con un’intensità oltremodo superiore rispetto al malvagio proselitismo d’antan; se s’affloscia poi risorge, ritorna, più o meno come un tramonto è sempre seguito da un’alba, in un esempio paradigmatico del concetto di recidiva; l’indole transnazionale del suo viaggio nello spazio inficia, o comunque rende più complicata, la giuridica possibilità di trascinare nelle aule di un tribunale un reo di diffamazione; e poi il lievito forse più grave, quello che l’autore dell’articolo mette in evidenza più degli altri: l’anonimato e tutto ciò che ne consegue.
Qui scatta il j’accuse contro una ormai famosissima figura di stronzo: il leone da tastiera. Con un metaforico passamontagna sulla testa, con il volto travisato come quello di un bandolero che nel commettere un reato pensi di sfangarla se non si faccia riconoscere da videocamere di sorveglianza o da testimoni non omertosi, il cattivo online fa assegnamento su un nickname, su una falsa identità, sulla magica invisibilità della sua vera identità per scatenarsi, con dionisiaco sollazzo, nell’hobby delle contumelie.
In questa dimensione è tecnicamente e fenomenologicamente più agevole il travestimento. Un rapinatore con la calza di nylon sulla testa è vistoso, trash, dà nell’occhio, e quello strumento di travisamento scotta, ha una durata a termine, è sempre lì lì per naufragare nell’avvento di un imprevisto -magari a sirene spiegate e pneumatici che sgommano- che possa vanificarne, in una terribile coupure, la sua funzione nell’essere un sedicente Altro. Il diffamatore social, invece, beneficia di un maggiore relax nel suo bluff esistenziale, corre un minor pericolo di essere preso con le mani nella marmellata, l’efficacia della sua copertura è più discreta e meno effimera. Il sozzo bastardo gongola e prospera in questa situazione -nella quale, appunto, Internet non ha colpa esattamente come il mare che ospita gli acuminati e granguignoleschi denti di un pescecane killer-. Egli, nella misura in cui ha così la possibilità di non lasciare impronte digitali sulla scena della delittuosa calunnia, può allegramente allontanarsi dal problema della responsabilità individuale, non più aggiogato dalle urbane redini di un deterrente senso di colpa. Così l’innocente infante che fu diventa, in una spregiudicatezza sempre più irrefrenabile e disinibita, un teddy boy dell’insulto, tanto non costa niente, tanto paga Pantalone -cioè ne si attribuisce la reità al medium, che nulla c’entra, e non a lui lui-.
Secondo Fornoni costui, qualora, puta caso, qualcosa vada storto nelle sue imboscate, poi versa, come un coccodrillo, delle lacrime di resipiscenza, forse più simulata in artata drammaturgia che veramente provata. Ammesso e non concesso che davvero lo sgamato hater, sputtanato da un fuoriprogramma e depotenziato nella sua vigliacca ostilità, si penta davvero, è un peccato che questa palinodia accada in un coccodrillo, un bestione che, se pure pianga, incute paura con il fisico che si ritrova.
Aggiungo una provocazione intellettuale. Finché verrà chiamato ‘leone’, e ‘coccodrillo’ se diventi un pentito, sarà difficile che ritorni a essere l’innocente bimbo di Nelson Mandela: si sentirà un qualcuno, un re della foresta, più ganassa di un lupo che perda il pelo ma non il vizio. L’ideale sarebbe chiamarlo, quando infanga a tradimento la reputazione altrui su una QWERTY, ‘acaro da tastiera’. Secondo me così forse il Nostro s’ammoscia e la smette.
Walter Galasso
